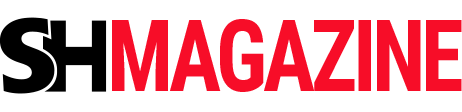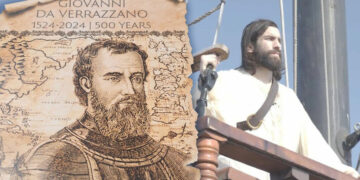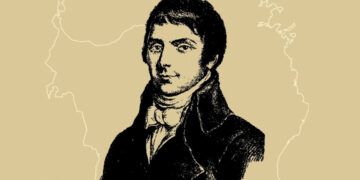Sul versante storico, la nostra isola è considerata unica nel suo genere in quanto caratterizzata dal delinearsi della civiltà nuragica.Sviluppatosi in un periodo compreso tra il 1700 e il 700 a.C., tale arco cronologico prese il nome dai nuraghi, costruzioni tronco-coniche in pietra disseminate su tutto il territorio.
Eppure, al pari delle edificazioni nuragiche altrettanto significativa fu la fase prenuragica, durante la quale si incrociarono popoli, usi, costumi ed abitudini diverse; dagli incontri e scontri di questi gruppi umani scaturirono differenti dinamiche, che interessarono anche la regione storica del Logudoro. Qui presero sede i Balari, – detti in sardo “Balares”–tribù giunta in Sardegna prima del nuragico, ma velocemente ambientatasi in tale contesto.
Forti e dall’indole ribelle, i Balares arrivarono in Sardegna intorno al 2000 a.C. e si stabilirono nel centro-settentrione dell’isola, in corrispondenza del vasto territorio logudorese. Secondo una leggenda riportata dallo scrittore e geografo Pausania, essi discendevano da soldati mercenari spagnoli ed africani affiliati a Cartagine, che si rifugiarono nella regione a seguito di contrasti con i punici. Di loro parlò anche lo storico Sallustio, il quale li descrisse come individui diffidenti “scuri di vesti, acconciatura e barba”. Il periodo nuragico rappresentò per i Balari un’affermazione della propria identità, giacché fu proprio in tale frangente che iniziarono a manifestare peculiare fierezza ed energia combattiva. Difatti, fin da subito si imposero sulle zone circostanti saccheggiando e conquistando i centri limitrofi.
Con l’avvento del potere romano in Sardegna, le abitudini del popolo guerriero non mutarono affatto e non fecero altro che rinsaldarsi. Nel 238 a.C. l’isola passò sotto controllo dell’Impero, il quale si pose l’obiettivo di portare ordine nelle frazioni occupate da tribù autonome. Tra queste vi erano anche i Balari – stanziati per la maggior parte nella regione storica di Monteacuto, tra Sassari e Nuoro – che nel frattempo continuavano a compiere scorrerie.
Per cercare di limitare i danni, i romani eressero baluardi allo scopo di respingere gli attacchi tribali e delimitare i confini con i loro domini; a nord il punto di delimitazione fu individuato presso il Monte Limbara (SS), soprannominato in latino “limes balares”, ossia “limite di delimitazione dei Balari”. Nondimeno, tali misure non spensero l’animo guerriero dei Balari, che si allearono con altre tribù e nel 181 a.C. dichiararono guerra agli invasori, venendo tuttavia sconfitti definitivamente qualche anno dopo. A causa della disobbedienza compiuta, le perdite umane furono tantissime e i superstiti vennero venduti come schiavi; negli anni però i romani non riuscirono mai a prevalere completamente, arrivando anche a sottoscrivere accordi di non belligeranza.

Nel periodo antecedente la pesante disfatta, i Balares ebbero modo di esprimere la propria decisione e forza attraverso la vita quotidiana. Da sempre abili navigatori, essi vivevano principalmente seguendo uno stile di vita mercenario, cioè basato sul depredare le ricchezze dei territori circostanti; presumibilmente ciò era legato anche all’area impervia in cui vivevano, che permetteva loro di non essere raggiunti dai nemici. Attualmente, tale zona corrisponde alla superficie compresa tra i paesi di Alà dei Sardi (SS), Buddusò (SS) e Bitti (NU).
Proprio in tale circoscrizione sono emerse alcune testimonianze attestanti il passaggio del popolo guerriero. Risulta suggestiva l’associazione con il sito archeologico “Su Pedrighinosu” ad Alà dei Sardi (SS), conosciuto anticamente come “Balare” e per questo definito ipotetica capitale del territorio tribale. Altro tassello importante è rappresentato dal cosiddetto “Cippo dei Balari”, stele rinvenuta presso il Rio Scorraboe e riprova della loro presenza. Essa infatti reca alcune iscrizioni, tra cui il termine “Balari”, informazioni sul governatore del tempo e la distanza della pietra dall’esatto punto di definizione confinaria. Inoltre, sempre lungo il Rio Scorraboe sono state rinvenute delle incisioni rupestri indicanti il fiume come spartiacque tra Balari e romani, proprio a ridosso di Monteacuto.
Popolo dallo spirito libero, i Balares trovarono nella Sardegna un posto sicuro per stabilirsi e potersi assicurare la sopravvivenza; giunti dall’esterno, essi seppero adattarsi al luogo e riuscirono a trasformare la situazione a proprio vantaggio. Malgrado oggi non rimangano molti segni, il loro passaggio è stato significativo e ha contribuito a rinvigorire la storia territoriale sarda.