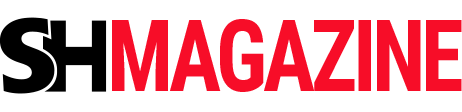Ci sono feste in cui i confini tra ciò che è pagano e cristiano si fondono sino a perdersi: in Sardegna, la ricorrenza di Sant’Antonio Abate è una di queste. Immancabilmente ogni anno, solo due settimane dopo l’inizio di gennaio, piazze e strade sono rischiarate dai colori e dal calore del fuoco, attraversate dalle maschere tipiche. È la sera del 16 gennaio, quella che, tra tradizione e ritualità, sancisce la prima uscita ufficiale delle grandi protagoniste del Carnevale sardo.
Sant’Antoni ‘e su fogu è il patrono della pastorizia e dell’agricoltura. Di lui la leggenda racconta che morì ultracentenario in un fatidico 17 gennaio e gli attribuisce il merito (non da poco) di essersi spinto nel profondo degli Inferi per rubare una scintilla di fuoco da donare agli uomini. Questi, infatti, sino ad allora avevano vissuto al freddo e al gelo, ignari dell’esistenza di questo elemento. Sant’Antonio riuscì nell’impresa anche se i diavoli cercarono di bloccargli l’ingresso; il porcellino che portava con sé, infatti, si avventurò oltre la porta degli Inferi creando un gran trambusto. Allora i diavoli gli concessero di entrare e lui, Sant’Antonio, raccolse insieme al piccolo animale una scintilla di fuoco, nascosta ai diavoli e ben custodita nel cuore del bastone di ferula.
Nella leggenda, quindi, motivi pagani e cristiani si fondono in un tutto in apparenza inestricabile. Per l’agiografia ufficiale, infatti, Antonio Abate (celebrato il 17 gennaio, giorno della sua morte) visse a cavallo tra il III e il IV sec. d.C. in Egitto, in un’epoca in cui il fuoco era tra le mani degli uomini da almeno due milioni di anni. Rimasto orfano e ricco, vendette tutti i suoi averi per ritirarsi nel deserto, in povertà, castità e preghiera. Qui la leggenda racconta che fu messo a dura prova dal demonio e che solo negli ultimi anni di vita, abbondonò la solitudine per vivere circondato da un gruppo di discepoli. Al momento della morte (avvenuta ad Alessandria all’età di 105 anni), furono proprio questi ultimi a seppellirlo in un luogo rimasto segreto.
Da allora sono passati più di duemila anni, ma ogni anno, tra il 16 e il 17 gennaio, Sant’Antonio Abate diventa protagonista dell’inverno sardo, celebrato con altissime pire di legna (lentisco, corbezzolo, alloro, rosmarino), chiamate a seconda delle zone tuvas, frascas, focos, fogarones, romasinus e foghidonis. All’imbrunire, acceso il falò benedetto dal parroco, fedeli e maschere vi girano intorno tre volte, prima in senso orario e poi in senso antiorario, recitando la loro preghiera al Santo.

Quanto e che cosa c’è di pagano in tutto questo? Molto. Il rito cristiano, infatti, appare costruito su un antichissimo rito pagano che simboleggiava la morte e la rinascita della divinità e, con questa, della natura. Lo testimonia la leggenda di Sant’Antonio (che rubando il fuoco ai diavoli per darlo agli uomini incarna un nuovo Prometeo, figura molto nota della mitologia greca, che, appunto, rubava il fuoco agli Dei per darlo agli uomini) e lo testimonia la presenza del maialetto al suo fianco, associato (sempre dai Greci) alla Dea Demetra, divinità della terra e delle messi.
La stessa ritualità legata alla festa è, inoltre, essa pure ricca di suggestioni pagane. I balli e i giri intorno al fuoco si ricollegano, infatti, ai ritmi in onore del Dio Dioniso, dove la perdita di controllo era il passo necessario per entrare in contatto con la divinità ed esserne “posseduti”. Indubbiamente pagana è pure la presenza delle maschere che, non a caso, “danzano” intorno ai falò per tre o tredici volte, numeri magici per eccellenza. E se tutto questo non bastasse, parlano di paganesimo anche i cibi associati alla festa di Sant’Antonio Abate: le arance, le cui foglie sono utilizzate per adornare le Chiese e i frutti (simbolo pagano di fecondità) impalati e mangiati intorno a sas tuvas. Come, del resto, anche le panadas di miele (alimento associato da sempre e in molte culture al culto dei morti).
Con Sant’Antonio, la Sardegna si conferma, quindi, terra di tradizioni antiche, le cui origini si perdono nella notte dei tempi; tradizioni così radicate nell’animo e nel cuore della sua gente da essere state per certi versi “accettate” e “inglobate” dalla religione cristiana che, arricchendole con i suoi simboli, gli ha dato (forse) nuova vita.