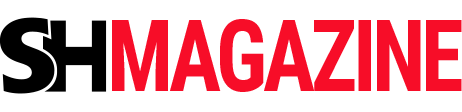Tra montagne maestose e natura selvaggia, la catena montuosa del Supramonte (NU) è attualmente mèta prediletta per percorsi di trekking ed escursioni. Oltre ad ospitare una fauna caratteristica, – come cinghiali, mufloni e il gatto selvatico – l’area in passato era sede anche dei pastori, figure importanti nell’immaginario sardo e soprattutto sul lato economico. Per proteggere sé stessi e il proprio bestiame, essi dovettero ingegnarsi e trovare strategie per il malagevole territorio in cui avevano scelto di stabilirsi. Da tale necessità nacquero “Sos Cuiles”, strutture dotate di capanne in uso fino alla metà del ‘900.
Traducibile in italiano come “ovile”, ad oggi “Su Cuile” rappresenta una delle ultime testimonianze della vita agro-pastorale del Supramonte. La sua origine sembra risalire ad un tempo molto lontano, in quanto già i popoli nuragici praticavano la pastorizia in quelle zone e avevano bisogno di luoghi per accudire gli animali. Data la pericolosità e l’asprezza delle aree montane, le comunità si servivano di questi punti di appoggio per proteggere il bestiame da predatori e poter lavorare al processo di produzione del formaggio.
La tradizione pastorale è un prezioso vanto per la Sardegna in quanto la sua pratica è una tra la più antiche dell’isola. Al centro di questa realtà vi era la figura del pastore, stabile collante col mondo naturale e dedito a tempo pieno alle sue greggi, da cui ricavava lana e anzitutto latte per fare il formaggio. Anticamente, il prodotto che ne risultava prendeva il nome di “Fiore Sardo” e passava per una serie di fasi che negli anni si tramandarono di padre in figlio. Per prima cosa, il latte derivato dalla mungitura degli animali – soprattutto ovini – veniva cotto in caldaia con il caglio d’agnello, sostanza che consentiva la coagulazione. Successivamente, la cagliata ottenuta veniva prelevata ed inserita nei cosiddetti “pischeddas”, matrici su cui il pastore faceva pressione per eliminare l’eccesso di liquido. Infine, dopo essere stata immersa in salamoia ed affumicata, la forma veniva lasciata a riposare in ambiente consono così da poter raggiungere un giusto tempo di stagionatura.
Come già accennato, per svolgere indisturbati la propria attività i pastori creavano appositi luoghi chiamati comunemente “Sos Cuiles”. Dal punto di vista costruttivo essi si componevano di una struttura principale, corrispondente all’area abitativa del pastore e detta “Su Pinnettu”. Essenzialmente l’abitazione si articolava in tronchi disposti verticalmente su base di pietra e la particolare conformazione tronco-conica la faceva somigliare ad una capannina, attorno alla quale si sviluppavano altre diverse parti. La dimora era inoltre dotata di “Su Cugumale”, sorta di rivestimento posto sotto le frasche che manteneva l’ambiente fresco e asciutto. Vicino al “pinnettu” si estendeva “Sa Mandra” (o “Sa Corte”), recinto ligneo entro cui stavano le capre e che proteggeva dalle incursioni di rapaci; altro spazio spesso presente era “Sa Cumbula”, adibito invece ai maiali. Sempre per questioni di sicurezza, l’intera superficie era circondata da un muro perimetrale, del diametro di circa 4 metri.



Dopo aver rappresentato per decenni un punto di riferimento, nel secondo dopoguerra “Sos Cuiles” furono abbandonati e caddero in disuso, venendo successivamente riabilitati grazie all’azione di associazioni e gruppi volontari. In particolare, l’opera di valorizzazione ha portato alla luce alcuni specifici siti, impressi nella memoria collettiva soprattutto per la nomea dei propri artefici. Tra quelli più noti vi è il dorgalese Billia Mereu, costruttore assai prolifico tra Baunei (NU) e Dorgali (NU): del suo passaggio rimangono suggestivi rifugi pastorali, come “Cuile Lupiru”, “Onammara” e “Cuile Mereu”. Di ulteriore supporto sono state anche le iniziative regionali, che hanno contribuito alla riqualificazione di aree comprese tra Urzulei (NU), Oliena (NU) e Orgosolo (NU).
Raccolti ed intimi, i confini de “Sos Cuiles” hanno accolto per tanto tempo i pastori e sono stati protagonisti di una tradizione che tutt’ora sussiste, sebbene in diverse forme e modalità. Mediante il recupero delle strutture decadenti, è stato possibile non solo riscoprire un corposo frangente di storia sarda, ma anche di acquisire più consapevolezza su quanta dedizione ci fosse – e ci sia ancora – in relazione ad un mestiere tanto antico.