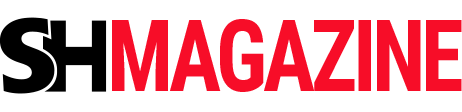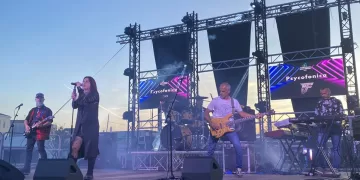Non sono in tanti ad aver vissuto l’emozionante esperienza di incontrarlo in natura, eppure tutti, pensando al cervo, non possono che immaginare “Bambi”, il dolce cerbiatto del capolavoro della Walt Disney che, tra gioie e dolori, cresce e affronta le varie tappe del ciclo della vita fino a diventare il maestoso principe del bosco.
È proprio nel cuore della foresta, tra le verdi radure e il suono del vento che soffia, che il cervo incede con un’andatura altezzosa e nobile, fin da tempi immemori.
Questo grande mammifero che appare come un’entità antica e misteriosa, capace di incarnare i valori della forza e dell’eleganza del mondo naturale, fa da guardiano anche ai boschi della Sardegna. Nell’Isola è presente, infatti, una sottospecie endemica del cervo europeo, quella del cervo sardo o cervo corso, scientificamente definito Cervus elaphus corsicanus, per via del suo primo avvistamento avvenuto storicamente proprio in Corsica.
Sull’origine del cervo sardo-corso sono state avanzate nel tempo diverse teorie.
Secondo una prima tesi, deriverebbe dai cervi dell’Italia peninsulare che, durante l’ultima era glaciale, avrebbero attraversato autonomamente un tratto di mare stretto e poco profondo fino a raggiungere le due isole che all’epoca erano unite. Un secondo orientamento sostiene invece che il cervo sardo sia stato importato, alla fine dell’età del Bronzo, direttamente dal Nord Africa ad opera dei Fenici, dapprima in Sardegna e poi anche in Corsica, probabilmente per impiegarlo in rituali sacri o come preda di caccia. Tuttavia, questa teoria è stata smentita dagli studiosi di archeozoologia che hanno rinvenuto dei resti appartenenti al cervo europeo risalenti addirittura al Neolitico, e dunque ad un’epoca molto precedente.
Ancora oggi il mistero non è stato del tutto chiarito, ma la teoria più accreditata, basata sulla comparazione del DNA dei cervi sardo-corsi con quelli dei resti dei cervi nati nella penisola, ha confermato la stessa discendenza e la loro introduzione in epoca preistorica, in Sardegna e in Corsica, ad opera dell’uomo.
Al di là della genesi comune, il cervo sardo presenta alcune caratteristiche morfologiche che lo distinguono da quello europeo. Di corporatura più piccola e esile, gli esemplari maschi sono alti circa un metro e non superano i 130 kg di peso, mentre le femmine sono alte circa 80 cm e pesano 70-80 kg. Il tronco e il collo sono lunghi e sottili, con una testa di forma triangolare e allungata, mentre gli arti appaiono corti e snelli, a dispetto della loro forza. Il manto, che sembra di seta, è di un colore più scuro rispetto a quello del cervo rosso, soprattutto in inverno, quando tende al grigio-bruno, mentre d’estate assume un colore tra il bruno e il rossiccio.
Le corna dei nostri cervi autoctoni, che vengono chiamate “palchi”, sono presenti solo nei maschi e anche in questo caso hanno dimensioni inferiori rispetto a quelle dei cervi europei, presentando una lunghezza di 70 cm e ramificazioni più semplici, con sole 4 o 6 punte invece di 16 o 24; non presentano, inoltre, la tipica corona. Altra particolarità degli esemplari maschi è la presenza, nella parte inferiore del collo, di un pelo fitto, lungo e scuro, tale da conferirgli le caratteristiche di una criniera.
L’habitat ideale del cervo sardo-corso è rappresentato dalle foreste tipiche della macchia mediterranea, dai cespugli e dalle radure, è invece difficile individuarlo in zone rocciose e con notevoli pendenze. Ciò è confermato anche dalle sue abitudini alimentari, questo animale è infatti un erbivoro ruminante, brucatore e pascolatore, si nutre di piante erbacee, di foglie e dei germogli tipici dei vari alberi, tra i quali i corbezzoli, oltre che di frutta.


Abbondantemente presente sia in Sardegna che in Corsica fino all’Ottocento, nel corso del Novecento il cervo sardo-corso ha subito un preoccupante declino, soprattutto a partire dal 1955, a causa della deforestazione, della perdita del suo habitat e del bracconaggio. Questo portò, alla fine degli anni Sessanta, a stimare una popolazione compresa tra i 100 e i 200 esemplari in Sardegna e alla completa estinzione in Corsica nel 1969.
A seguito di questi avvenimenti, a partire dal 1985 in Sardegna fu avviata un’opera di tutela e di incremento della popolazione soprattutto da parte del WWF.
Attualmente, i cervi sardi sono presenti in tre aree del sud Sardegna: nel Sarrabus, nel Sulcis e nella zona di Arbus; sono poi stati reintrodotti in altre zone dell’Isola, tra cui Villacidro, Seui, Urzulei e Pattada.
Il cervo sardo-corso, ancora oggi, continua comunque ad essere considerato come una specie vulnerabile e da proteggere. Ogni anno, in genere nel mese di settembre, la fondazione WWF Italia organizza il suo censimento presso l’Oasi del Cervo e della Luna situata nel territorio della Riserva naturale di Monte Arcosu. Gli appassionati e i volontari possono iscriversi e unirsi agli operatori per partecipare al conteggio degli esemplari, avendo così l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile trovandosi finalmente al cospetto del “signore” delle foreste dell’Isola.