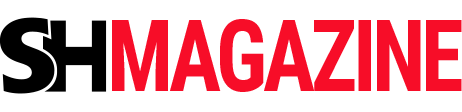L’azzurro del mare, il verde della vegetazione e le inedite sfumature delle architetture: nel comune di Iglesias (SU) i colori non mancano e creano per chi lo vive – da abitante o visitatore – un quadro unico di tradizioni e ricchezze naturali. Tutte sfaccettature che portano con loro anche storie individuali, collettive ma soprattutto identitarie e rendono l’area sede di luoghi significativi come la Miniera di Monteponi, luogo simbolo della storia mineraria iglesiente.
Sita a pochi chilometri da Iglesias, la miniera di Monteponi è tutt’ora considerata tra i luoghi più evocativi del passato estrattivo locale, con un’attività rimasta operativa fino alla seconda metà del XX secolo. Frequentata già nel 1600 da cavatori e diventata nel 1725 sede di una prima fonderia, solo a partire dal 1848 essa sperimentò il massimo potenziale con la cosiddetta “Legge degli Stati Sabaudi”, che delegò a direttive statali la concessione di risorse del sottosuolo di un terreno privato e permise a terzi di sfruttarle secondo specifici requisiti tecnico-economici.
Una nuova disposizione che vide l’avvicendarsi di diversi interventi, a partire da quelli del gruppo imprenditoriale di Monteponi presieduto dal banchiere Paolo Antonio Nicolay,che oltre a un pensato programma di sfruttamento introdusse attività metallurgiche e acquistò per una nuova fonderia la tenuta di Canonica, al tempo appartenente al conte Carlo Baudi di Vesme.
A partire dal 1861, sotto la guida del nobile destinato a diventare socio del gruppo imprenditoriale, il sito di Monteponi crebbe notevolmente, trasformandosi in un polo estrattivo avanzato. L’attività era incentrata sull’estrazione di piombo, zinco e argento e si estese ad altre aree, tra cui la vicina miniera di San Giorgio, con il pozzo di Santa Barbara (conosciuto anche come “Sa Macchina Beccia”, ovvero “la macchina vecchia”), e quella di Campo Pisano. In questa fase si investì non solo sulle risorse minerarie, ma anche sulle infrastrutture e le attrezzature. Tra gli interventi principali, vennero realizzati la galleria Marchese di Villamarina, i pozzi Vittorio Emanuele II e Quintino Sella (risalenti alla metà del XIX secolo), una via ferrata e nuovi edifici industriali, tra cui le laverie semiautomatiche Villamarina e Nicolay.
Preposto alla separazione del minerale dai materiali grezzi, il lavoro in laveria fu centrale nel ripensare l’ampliamento degli impianti negli ultimi decenni del XIX secolo. Assieme alle semiautomatiche, Monteponi accolse infatti strutture più moderne e meccanizzate, dalla laveria Calamine – atta a trattare ciò che proveniva dall’area di Is Cungiaus e luogo di sperimentazioni come la cernitrice magnetica per separare i materiali – a quella intitolata a Vittorio Emanuele per lavorare il minerale grezzo fino alla laveria Mameli, sorta con il compito di occuparsi invece di materiali fini.
Importanti novità ci furono anche sul fronte della manodopera con l’introduzione da metà ‘800 delle donne in processi al di fuori della galleria, come la cernita e il lavaggio dei minerali con arnese dotato di telaio. Se da una parte la nuova situazione ridusse tempi di produzioni e costi, – in quanto le lavoratrici, per la maggior parte giovanissime, risultavano più svelte degli uomini malgrado la paradossale paga dimezzata – dall’altra le condizioni disumane e la precarietà comportavano rischi elevati, che culminarono nel 1871 nella morte di 11 donne a seguito del crollo di una cisterna.Un incidente tra i più tragici della storia lavorativa femminile isolana, divenuto negli anni a venire scintilla per una forte presa di coscienza e ribellione.






Apparenti luci e tante ombre nascoste, che non impedirono tuttavia nel tempo di affiancare al sistema minerario un villaggio ospitante fino a 1000 operai, dotato di scuola, una chiesa intitolata a Santa Barbara, un ospedale e architetture evocative come Palazzo Bellavista. Concepito dall’ingegnere Adolfo Pellegrini nel 1865 con pianta “a U” e giardino retrostante tutt’ora visibile, l’elegante edificio accolse in un primo momento la dirigenza della miniera e poi anche gli uffici, assistendo nel 1875 al passaggio di direzione a Erminio Ferraris.
Creatore nel 1889 della Galleria Umberto I, il suo operato è attualmente ricordato dalla collezione dell’Associazione Erminio Ferraris,nata nel 1915 per supportare attività sportive, artistiche e culturali tra gli operai del Dopolavoro. Ospitato nella stessa palazzina, il repertorio custodisce interessanti materiali come volumi e testi di lettura, una delle prime stampanti elettriche, un antico apparecchio televisivo e radiofonico più fotografie relative al Dopolavoro.
Attività per il tempo libero praticate dagli anni ‘30 del ‘900 fino alla chiusura delle operazioni estrattive, il Dopolavoro accompagnò Monteponi sino alla seconda metà del secolo, quando forti disagi per costi elevati dell’energia elettrica, l’impoverimento dei giacimenti e il crollo dei prezzi nei mercati internazionali condussero a una definitiva chiusura nei primi anni ‘90. Una fine che non intaccò tuttavia la bellezza storico-culturale del sito, recuperata con un restauro della società Interventi Geo Ambientali (IGEA S.p.A).
La miniera di Monteponi si trova a Iglesias (SU) ed è raggiungibile dalla Strada Statale 126. Per informazioni è possibile consultare il sito internet iglesiasturismo.it.