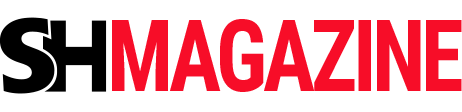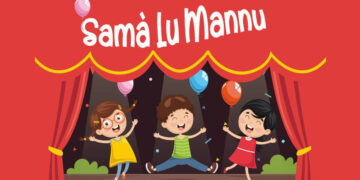In Sardegna sono 39.374 le imprese guidate da donne, registrate presso le Camere di Commercio, che operano per lo più nei settori dei servizi alla persona e della pulizia, della moda e delle attività di ristorazione: queste rappresentano il 22,9% di tutte le realtà produttive dell’Isola e danno lavoro a più di 120mila dipendenti. Ben 4.327 aziende sono gestite da giovani donne. Su tutta la platea delle donne imprenditrici, quasi 5.946 sono imprese artigiane (il 15,1% su tutte le imprese al femminile). Ed é proprio sul lavoro delle donne che si è abbattuta con maggior violenza la forza della crisi Covid: i numeri, anche se in leggera ripresa evidenziano come queste oggi lavorino meno e siano anche più disoccupate rispetto al 2019.
A livello territoriale, nella vecchia provincia di Cagliari le imprese donna sono 16.114 di cui 2.465 artigiane (15,3% sul totale imprese donna), su Sassari-Gallura sono 12.672 di cui 2.075 artigiane (16,4%), a Nuoro sono 7.456 di cui 1.056 (14,2%) artigiane e a Oristano 3.132 con 350 artigiane (11,2%).
Sono questi alcuni dei dati che sono emersi dall’analisi sulle imprese al femminile realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna e presentati durante l’iniziativa regionale dedicata alle donne di Sardegna che progettano il futuro, dal titolo “SWAE, Sardinian Women, Artisan Empowerment”, svoltasi questa mattina a Oristano, con la collaborazione di Artigiancassa.
I dati hanno anche ricordato come nel periodo della pandemia nel Paese si sia registrato un calo del 7,8% dell’occupazione femminile indipendente, a fronte del -6,1% registrato dalla componente maschile. Trend negativo anche sul fronte del fatturato delle imprese guidate da donne con una diminuzione di 4,4 punti rispetto alla media. Non va meglio per quanto riguarda gli impegni familiari dove le donne, nel ruolo di genitore, a causa della chiusura delle scuole durante la pandemia hanno sopportato un carico di lavoro doppio rispetto agli uomini.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro l’occupazione rimane inferiore dello 0,8% rispetto ai livelli pre-crisi e si registra un calo dell’1,1% della componente femminile di intensità doppia rispetto a quella degli uomini (-0,6%). Un’analisi della dinamica dell’imponibile della fatturazione elettronica per settori, che considera il peso settoriale delle imprese femminili, evidenzia che i ricavi delle imprese femminili sono di 4,4 punti percentuali inferiori rispetto alla media.
Ai record negativi però si accompagnano anche primati positivi del nostro Paese che è al primo posto in Europa per il maggior numero d’imprese a conduzione femminile, ben 1.336.227. Se l’Italia è il “Paese dell’anno”, come ha decretato “The Economist”, questo numero dimostra che il merito è anche delle donne e della loro grande capacità di reagire e affrontare un momento così difficile come quello vissuto con la pandemia.

Il sondaggio nazionale di Confartigianato sulle donne imprenditrici
Confartigianato, a livello nazionale, ha elaborato un sondaggio con l’obiettivo di capire come le imprenditrici artigiane avessero iniziato questo 2022.
Dalle risposte, sono essenzialmente due le parole chiave che sono apparse in ogni risposta: fatica e resilienza.
Fatica, perché nonostante il 2021 sia stato l’anno della ripartenza, le MPI e imprese artigiane femminili non sono state in grado di recuperare i livelli di fatturato pre-crisi e hanno registrato una variazione media dei ricavi, nel 2021 rispetto al 2019, negativa del -9,7%, più pesante rispetto al -8,8% totale. Tale risultato trova spiegazione nella maggior presenza di artigianato capitanato da donne in alcuni dei settori più colpiti dalla crisi Covid-19 come quello della moda e del benessere.
Resilienza, perché anche se più colpite dalle conseguenze della pandemia, le imprenditrici artigiane si dimostrano più combattive e pronte a reagire adottando, o esprimendo l’intenzione di adottare nel prossimo futuro, una o più azioni di sviluppo per riuscire a restare sul mercato incrementando la propria capacità competitiva, come dichiarato dal 61,2% di loro, quota superiore al 55% totale.
Su queste difficoltà, le azioni per ripartire maggiormente intraprese dalle donne a capo d’impresa sono state: il miglioramento della qualità del personale attraverso la formazione o nuove assunzioni e il cambiamento dell’organizzazione interna all’impresa. La scelta ad indirizzarsi principalmente verso questi due ambiti di sviluppo da evidenza di come le donne, più degli uomini, vogliano ripartire e recuperare il terreno perso partendo in primis dalle persone e non dall’integrare modifiche che riguardano prettamente l’organizzazione del business dell’azienda intervenendo su produzione, canali di vendita o clienti.
La maggior fatica e il grado sempre più elevato di complessità che caratterizza il contesto in cui le imprese operano fa si che siano proprio le imprenditrici quelle per cui si rileva una quota maggiore di incerte rispetto alla capacità di recuperare quanto perso a causa della volatilità odierna e futura che caratterizza, e caratterizzerà in futuro, il mercato (65,1%>58,7% totale). Mentre la quota di coloro che hanno già recuperato quanto perso si attesta al 16,5% e quella di coloro che pensano di essere in grado di recuperare i livelli pre crisi di fatturato entro la fine dell’anno in corso si attesta al 14,9%.
Seppur molto incerte, le donne che gestiscono imprese artigiane, interrogate sulla volontà di voler investire nel 2022 rispondono in modo affermativo nel 65,7% dei casi (> 62,9% del totale). Come per le azioni di sviluppo anche rispetto alle aree di investimento si osserva una predisposizione maggiore della platea femminile a voler puntare su capitale umano e formazione.
Sempre secondo l’analisi delle risposte del sondaggio, continuano a persistere le medesime disparità tra uomo e donna. Le donne, nonostante abbiano migliori risultati sul fronte istruzione e formazione, scontano gap rilevanti a loro sfavore sul fronte lavoro, conciliazione e benessere soggettivo. Difatti, la quota di donne imprenditrici con almeno un diploma si attesta al 69% superando di 6,8 punti quella rilevata per gli uomini (62,2%), quella di donne laureate si attesta al 38,3% superando di 10,8 punti quella rilevata per gli uomini (27,5%), quella di donne che hanno effettuato il passaggio all’università si attesta al 61,4% superando di 11,2 punti quella rilevata per gli uomini (50,2%). Mentre la quota di coloro che partecipano alla formazione continua eguaglia quella degli uomini (pari al 7,9% in entrambi i casi).
C’è però un ambito dell’istruzione in cui le donne scontano un gap a loro sfavore rispetto agli uomini, quello del digitale: per quota di donne con competenze digitali elevate (per le donne si registra una quota del 23,4% inferiore di 6,3 punti a quella degli uomini di 29,7%) e per quota di laureate (per le donne si rileva una quota del 10,3% inferiore 7,5 punti quella degli uomini di 17,8%). La platea femminile inoltre sconta condizioni peggiori degli uomini in tutti gli ambiti del lavoro e conciliazione con quote superiore a quelle dei colleghi maschi di 4,4 punti per il tasso di mancata partecipazione al lavoro (pari al 12,9% per le donne> dell’8,5% degli uomini), di 3,8 punti per dipendenti con bassa paga (pari all’8,9% per le donne > del 5,1% degli uomini), di 1,4 punti per occupati sovra istruiti (pari al 22,8% per le donne >del 21,4% degli uomini) e di 12,2 punti per part time involontario (pari al 16,7% per le donne> del 4,5% degli uomini).
Tutto ciò comporta una disparità uomo donna anche sul fronte della soddisfazione per il proprio tempo libero: le donne che esprimono livelli elevati di soddisfazione sono il 69,8% quota inferiore di 3,3 punti rispetto a quella rilevata per gli uomini (73,1%). Persiste inoltre una disparità del 31,1% tra la retribuzione media percepita dalle dipendenti donne rispetto a quella percepita dagli uomini.
Da qui la domanda: come ridurre la disparità a favore dei contesti a misura di donna?
I margini di miglioramento su cui poter intervenire, stando ai numeri descritti fino ad ora, sono diversi. Sempre facendo riferimento ai dati e ai risultati ottenuti dall’analisi si evince l’importanza e la centralità dell’istruzione e dei servizi di assistenza negli ambiti della conciliazione (come detto, i servizi per l’infanzia, asili nido) per spingere una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Difatti si osservano tassi di occupazione femminili più elevati proprio nelle realtà in cui c’è una maggiore diffusione di bambini che frequentano gli asili nido e di donne che hanno titoli di studio elevati (laurea e post-laurea).