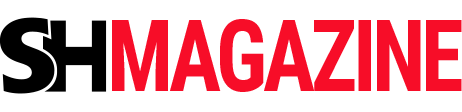Migrare è uno degli istinti degli animali. Persino l’uomo migra dall’alba dei tempi, spostandosi alla ricerca di ambienti più favorevoli in cui vivere. Ci sono tante cause che possono provocare una migrazione: la carenza di cibo, un pericolo, il desiderio di cambiamento. Esiste un tipo di migrazione che pare però dimenticata e sembra essersi persa nei meandri della storia insieme a quei mestieri che stanno sparendo. Stiamo parlando della transumanza. A molti potrà sembrare strana questa parola, sicuramente poco frequente nel linguaggio di tutti i giorni. Riportata all’attenzione dei più dal comitato del patrimonio mondiale dell’Unesco (che, a Bogotà, nel 2011, l’ha dichiarata “patrimonio culturale immateriale dell’umanità”), la transumanza indica una pratica relativa alla pastorizia e che consiste nella migrazione stagionale dei pastori e del bestiame.
Le radici della transumanza sono antichissime. A vantare il primato di più antico cammino della transumanza pare sia quello della Val Senales, in Alto Adige, le cui origini sono fatte risalire addirittura al periodo preistorico. A provocare nei pastori l’esigenza di spostare le greggi a seconda delle stagioni e del clima, erano fattori come la scarsità dei pascoli e la temperatura sfavorevole. Queste condizioni portavano i pastori a dover trovare delle soluzioni per garantire la salute ai propri animali, da cui dipendeva il loro stesso sostentamento. In Italia la migrazione di pastori e bestiame avveniva principalmente dall’Appennino abruzzese verso le regioni della Maremma toscana e laziale e del Tavoliere delle Puglie. Tuttavia, possiamo dire che la transumanza (il cui nome deriva dal verbo “attraversare”) sia un’usanza che – almeno storicamente – ha abbracciato tutta Italia e più in generale tutte le regioni alpine e mediterranee. Si tratta di una tradizione così antica da essersi “scolpita” nel terreno, lasciando come testimonianze i cosiddetti tratturi, ossia dei veri e propri sentieri calpestati, originatisi da continuo passaggio delle greggi e degli armenti.
Ad oggi, con l’avvento della zootecnia e l’affermarsi dell’allevamento intensivo, la transumanza sembra essere quasi scomparsa. Questa tradizione tipica dell’allevamento persiste in poche aree in Italia, come le località alpine del Trentino, della Valle d’Aosta e del Piemonte, le aree appenniniche di Molise, Abruzzo, Lazio e Puglia e, naturalmente, la nostra amata Sardegna.
La Sardegna è una terra ricca di tradizioni frutto di una cultura radicata nella terra e della natura. Ecco perché non stupisce che anche un’antica usanza come la transumanza sia sopravvissuta proprio nella nostra isola. A praticare la transumanza (in sardo sa tramuda) sono i pastori di Villagrande e Arzana che, in primavera, portano i loro animali verso il Sarrabus. Siccome la Sardegna è anche una terra che si nutre di turismo (sia interno che esterno) la transumanza è diventata presto anche un evento partecipativo, un modo di riunire turisti e curiosi alla scoperta degli antichi sentieri dei pastori sardi.
Molti pastori si sono organizzati nel corso degli anni per far conoscere questa tradizione, proponendo al pubblico, come vere e proprie guide turistiche, percorsi più o meno brevi tra i cammini della transumanza. Nel 2019, oltre 100 persone hanno percorso insieme ai pastori alcuni tratti del percorso di 30/60 km che in primavera conduce il bestiame di Arzana e Villagrande verso le aree marine di Tortolì e del Sarrabus. A causa del Covid, l’anno scorso, ad Arzana, la transumanza si è fatta addirittura in diretta Facebook.

📷 Romolo Eucalitto 
La crescente attenzione nei confronti di sa tramuda – che si sta imponendo come importante interesse turistico – ha portato a gennaio 2021 l’Associazione Ogliastra Eventi con il contributo della Fondazione di Sardegna a promuovere il progetto “I cammini della transumanza”. L’obiettivo è valorizzare e far conoscere ancora di più le vie dei pastori a fini turistici ed escursionistici. Il progetto prevede la raccolta di una serie di interviste che andranno poi a formare una sorta di guida-racconto, con l’intento di riportare l’attenzione sul mondo agro-pastorale sardo. La Sardegna, d’altronde, è la prima regione del Mediterraneo per l’allevamento degli animali da pascolo.
Il progetto dell’Associazione Ogliastra Eventi non ambisce soltanto alla valorizzazione di un’antica usanza della Sardegna, ma mira a un cambiamento dell’approccio tra turismo e cultura. Uno degli intenti chiave del progetto, infatti, è quello di dare una svolta digitale al turismo tradizionale, con lo sviluppo di app e strumenti per la geolocalizzazione che permetteranno ai turisti di calpestare le vie della transumanza e riportare alla luce la memoria dei pastori servendosi dei loro dispositivi digitali. L’approccio è anche multicanale: le voci dei pastori saranno poi narrate in uno spettacolo teatrale allo scopo di coinvolgere il pubblico nella narrazione della transumanza.
Portare alla luce le vie della transumanza significa dare nuova linfa vitale alla nostra tradizione, evitando che si perda. Le attività tradizionali come l’allevamento del bestiame fanno sì che alcune aree interne (che si vanno spopolando a vantaggio delle regioni costiere) continuino ad essere abitate e a destare l’interesse delle persone. In questo modo, non solo la produzione di svariati beni non industriali (come i formaggi tradizionali ad esempio) non andrà perduta, ma anche il paesaggio, la biodiversità, il benessere degli animali e la qualità della vita ne trarranno beneficio. Ecco perché progetti come questo non possono che far bene alla nostra isola.