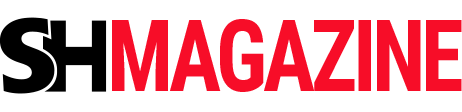Dormire per mesi o anche per anni senza rispondere agli stimoli per sottrarsi a un’esistenza che fa paura. È stata chiamata in diversi modi: “sindrome della rassegnazione”, “sindrome del rifiuto traumatico”, “sindrome del sonno profondo”, persino “sindrome della bella addormentata”. Da alcuni è considerata un mistero, da altri una disgrazia e si tratta di una malattia che colpisce soprattutto i minori rifugiati, ma non solo.
Negli scorsi giorni ha avuto molta risonanza la triste vicenda del detenuto, un ventottenne originario del Pakistan, rinchiuso nel carcere romano di Regina Coeli. Il personale del penitenziario lo ha soprannominato “il simulatore” perché sembra che simuli di essere morto. I suoi occhi, infatti, sono sempre chiusi e si trova sdraiato immobile sul letto della sua cella da circa quattro mesi. Gli infermieri hanno raccontato che gli svuotano il catetere, gli cambiano il pannolone e gli infilano del cibo liquido in bocca che poi l’uomo deglutisce in maniera meccanica. In Italia il caso ha suscitato sia preoccupazione che curiosità e sono tanti coloro che si sono domandati quale sia la causa di questa condizione, visto che dai controlli dei medici non è stato riscontrato nulla di oggettivo. Ma se non ha evidenti problemi di salute, da cosa è affetto?
La sua condizione potrebbe chiamarsi appunto “sindrome della rassegnazione”. Questa patologia di tipo psicologico non riguarda solo i carcerati ma, anzi, colpisce per lo più i bambini e gli adolescenti di un’età compresa tra gli 8 e i 15 anni che hanno subito dei gravi traumi e violenze. La sindrome è stata segnalata per la prima volta in Svezia negli anni ’90 in centinaia di bambini e ragazzi accomunati tutti dalla stessa caratteristica, ovvero lo status di rifugiato. Secondo i dati del Comitato Nazionale di Sanità Svedese, ad essere stati interessati dalla sindrome in Svezia sono tutti richiedenti asilo provenienti dai Paesi dell’ex Unione Sovietica, dalla Jugoslavia e più recentemente anche dalla Siria. La pesante situazione psicologica che i ragazzi devono affrontare in quei momenti li tramuta in soggetti privi di qualsiasi reazione, portandoli ad allontanarsi da un mondo che crea loro angoscia. Nel 2017 i casi svedesi sono stati documentati anche dal giornalista e fotografo Magnus Wennman, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.
La questione si è trasformata presto in un tema politico. Inizialmente, in molti hanno ipotizzato che i giovani catatonici fingessero per evitare di essere rimpatriati, ma tutti i medici che hanno seguito i casi hanno negato che potesse trattarsi di una pura simulazione. Per diversi anni la patologia non è stata riconosciuta dai pediatri e dagli psichiatri, solo a partire dal 2014 il Consiglio Nazionale Svedese per la Salute e il Benessere ha identificato questa sindrome con una diagnosi ufficiale, inserendola nella Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD10).
Come si legge sul sito dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, la sindrome della bella addormentata si manifesta con i sintomi tipici dell’ansia e della depressione, in particolare l’apatia e la letargia. I bambini, gli adolescenti e anche gli adulti che ne soffrono, piano piano iniziano ad essere irritabili, si isolano dall’ambiente circostante chiudendosi in se stessi e non riescono ad impegnarsi nelle attività di tutti i giorni, come la scuola e il gioco. Inoltre, non rispondono ai tentativi altrui di assistenza e diventano incapaci di parlare, camminare, mangiare, fino a diventare fragili, fiacchi, schivi, incontinenti e privi di reazioni davanti a stimoli fisici.
I soggetti affetti dalla sindrome della rassegnazione si ritrovano quindi in una condizione di profonda incoscienza che può durare anche per tanti anni. Devono essere nutriti e idratati artificialmente e dipendono totalmente dalle cure del personale sanitario. L’Ospedale Bambino Gesù precisa che in questi casi è fondamentale cercare di mantenere in vita le funzioni vitali, assicurando sostegno nutrizionale attraverso le flebo e un sondino gastrico. Inoltre, fin dall’inizio, la cura è anche di tipo psicologico. Per uscire da questo tunnel gli individui (e anche le loro famiglie) devono essere seguiti da professionisti che offrano loro un supporto psicoterapeutico, per far sì che riescano a rielaborare le emozioni negative associate all’esperienza traumatica che hanno vissuto e che siano in grado di inserirsi nel nuovo contesto socioculturale.