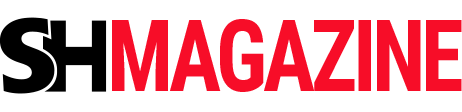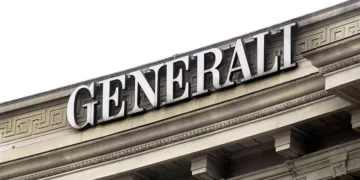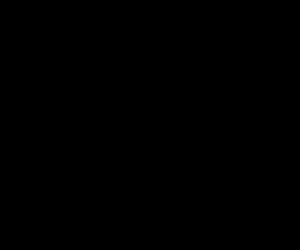(Adnkronos) – “La velocità di adozione conta quanto o più della velocità di scoperta”. È il cuore della relazione del presidente del Centro Economia Digitale, Rosario Cerra, che oggi presenta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la partecipazione del ministro Giancarlo Giorgetti, il Rapporto Strategico “High-Tech Economy. Il nuovo ciclo competitivo globale”, scritto insieme al professor Francesco Crespi. Ad aprire il rapporto, gli interventi di manager che rappresentano l’ossatura tecnologica e infrastrutturale del Paese, gran parte dei quali sono saliti sul palco durante la presentazione: Claudio Descalzi (Eni), Giuseppina Di Foggia (Terna), Stefano Donnarumma (Fs), Giuseppe Gola (Open Fiber), Nicola Lanzetta (Enel), Massimo Sarmi (FiberCop), Claudio Bassoli (Hpe), Vincenzo Esposito (Microsoft), Gianmatteo Manghi (Cisco), Giulia Gasparini (Aws), Melissa Ferretti Peretti (Google). Un messaggio politico-industriale consegnato al luogo dove si prendono decisioni che muovono investimenti, incentivi e regole.
Perché la high-tech economy è il nuovo ciclo competitivo. Il rapporto del Ced sostiene che non siamo di fronte a una semplice “ondata tech”, ma all’apertura di un ciclo competitivo globale innescato dalla convergenza di tecnologie di frontiera: intelligenza artificiale generativa, sistemi quantistici, biotecnologie avanzate, automazione intelligente, nuove tecnologie energetiche e ambientali, materiali innovativi e infrastrutture digitali pervasive. Non è un elenco, è una mappa: ciò che conta è la capacità di integrare queste tecnologie nell’economia reale, su larga scala, per generare crescita sostenibile, sicura, resiliente e inclusiva. La high-tech economy, per il Ced, non coincide con un settore ma con un paradigma trasversale di adozione efficace.
Nella sua relazione, Cerra incardina questa lettura su un punto essenziale: il vantaggio competitivo non spetta solo a chi crea tecnologia, ma a chi la adotta e la integra più rapidamente ed efficacemente nei processi produttivi, nei servizi e nella pubblica amministrazione. In altre parole, il “time-to-adoption” diventa metrica di potere economico. Da qui il punto di partenza comune che si è aperto per i Paesi: la possibilità di riposizionarsi dipende dalla tempestività delle scelte, dall’orchestrazione di capitale umano, dati, infrastrutture e governance.
La corsa sfrenata della Silicon Valley. Se in Silicon Valley si corre velocissimo, il messaggio del Ced è che l’Italia non può permettersi il lusso di aspettare. La natura esponenziale dell’innovazione amplifica i costi del ritardo: chi non integra in fretta le tecnologie chiave viene espulso dai circuiti della competitività, con effetti su produttività, occupazione qualificata, sovranità tecnologica, sicurezza e benessere. La risposta proposta è una strategia che favorisca l’assorbimento dell’innovazione lungo tutte le filiere — non solo nuova r&s, ma soprattutto diffusione e uso “capillare” delle tecnologie emergenti.
I numeri che contano: moltiplicatori, produttività, lavoro. L’analisi econometrica del rapporto offre l’argomento più persuasivo: nei 14 Paesi Ocse analizzati, ogni dollaro di valore aggiunto generato nei comparti high-tech attiva in tre anni 3,18 dollari di pil, contro 1,23 nei comparti a bassa tecnologia; nel sotto-campione europeo il moltiplicatore medio sale a 3,9 (contro 1,28). L’effetto non è temporaneo: nei settori low-tech si attenua, in quelli high-tech cresce nel tempo. Sul fronte della produttività, uno shock di 10 miliardi di dollari nei comparti high-tech produce +0,22% nei Paesi Ocse e +0,59% nell’Europa analizzata, contro +0,02% e +0,04% dei comparti low-tech. Anche l’occupazione beneficia: +177 mila posti medi in tre anni nell’Ocse e +161 mila nell’Ue, contro +68 mila e +47 mila nei settori a bassa tecnologia. Sono dati che smentiscono il luogo comune “tech = meno lavoro”: la tecnologia, se adottata bene, crea occupazione netta e più qualificata.
L’Italia tra manifattura di qualità e export high-tech in crescita. La fotografia comparata mostra un’Europa che ha perso quota nella produzione globale a più alta intensità tecnologica rispetto a Stati Uniti e Cina, ma con nicchie di forza: la specializzazione europea – in particolare di Germania e Italia – resta robusta nella manifattura a medio-alta tecnologia. Per l’Italia, il rapporto rileva una traiettoria positiva dell’export high-tech sul pil, cresciuto dall’1,4% del 2010 al 2,7% nel 2024, segnale di una proiezione tecnologica che si consolida anche se i livelli assoluti restano inferiori ai principali partner. È una base da cui partire, purché la diffusione tecnologica esca dalle “isole di eccellenza” e diventi sistema.
Dal “technology-push” al “demand-pull”: cambiare marcia. Dalla Strategia di Lisbona in avanti, l’Europa ha privilegiato politiche di offerta (finanziare la ricerca) senza sciogliere tre nodi: frammentazione degli ecosistemi, scarso coordinamento tra politiche della ricerca, industriali e digitali, domanda privata troppo debole di tecnologie. Il Ced propone un cambio di paradigma: stimolare la domanda di adozione tecnologica con incentivi mirati, fiscalità pro-innovazione, standard comuni, formazione delle competenze; e, sul lato pubblico, con appalti innovativi, digitalizzazione profonda delle amministrazioni, “missioni” tecnologiche chiare. È la via per fare della dimensione del mercato europeo – domanda sofisticata e filiere ricche – un asset competitivo globale.
Coopetizione e alleanza transatlantica: competere cooperando. Nel lessico del Ced torna la “coopetizione”, al centro del rapporto 2024 presentato alla Farnesina: combinare competizione e cooperazione tra sistemi complementari per scalare più in fretta tecnologie e mercati, mantenendo fiducia e governance “by design”. In questo schema, l’alleanza Ue-Usa è vista come moltiplicatore naturale: leadership americana nell’innovazione radicale, piattaforma scientifica, domanda avanzata e base produttiva europea per integrare tecnologie nei sistemi industriali. È una strategia industriale che punta a sicurezza, resilienza e autonomia strategica senza rinunciare all’apertura.
Cosa fare subito. Presentare il rapporto al Mef, davanti ai vertici delle aziende di rete, energia, cloud, calcolo e connettività, rende operativa l’agenda: servono condizioni “pro-investimento” per attrarre e trattenere high-tech companies in Italia – infrastrutture digitali ed energetiche, capitale umano, corsie autorizzative rapide, meccanismi fiscali di adozione, certezza regolatoria – e un coordinamento che trasformi casi di successo in standard di filiera. È qui che la velocità di adozione si misura davvero: negli acquisti pubblici che tirano il mercato, nei cluster che uniscono grandi player e Pmi, nelle competenze che le imprese trovano (o formano) sul territorio.
La posta in gioco. La scelta è binaria: o l’Italia accelera la transizione verso la high-tech economy oppure si rassegna a un sentiero di crescita anemica e dipendenza tecnologica. Cerra nella sua relazione non lascia ambiguità: investire oggi in tecnologie, persone, infrastrutture di nuova generazione e in una governance lungimirante è l’unico modo per garantire traiettorie di sviluppo sostenibile e per rafforzare sicurezza, resilienza e autonomia strategica del sistema Paese. E farlo in fretta, perché mentre discutiamo in California stanno già iterando la versione successiva.